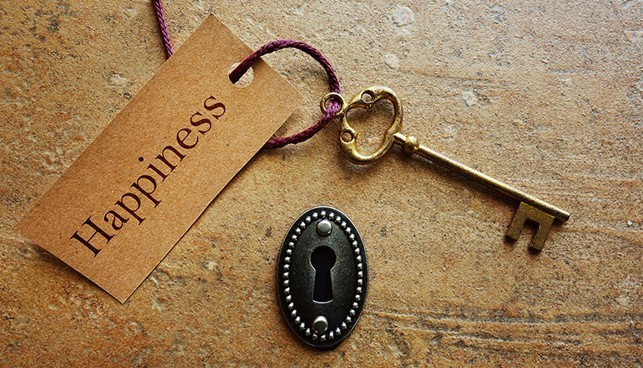“Ovviamente nella vita ci sono un mucchio di cose più importanti del denaro. Ma costano un sacco di soldi!” L’arguta ironia di Groucho Marx, ci ricorda l’idea diffusa che il denaro renda felici o che comunque ci sia una forte correlazione positiva tra denaro e felicità. In molti guardano con invidia le persone ricche nella istintiva convinzione che la loro ricchezza sia sinonimo di felicità. Ma è davvero così? Negli ultimi 50 anni sono stati molti gli economisti e psicologi che hanno tentato di rispondere a questa domanda. Infatti, l’economia classica presume che i livelli di benessere degli individui siano collegati al grado di soddisfazione dei bisogni e che a livelli di consumo più elevati corrispondano livelli più elevati di benessere ed in ultima analisi di felicità. Tutto ciò corrisponde alla realtà?
Tra i primi studiosi moderni ad interessarsi al tema vi è stato Richard Easterlin, professore di economia in California, che elaborò il famoso «paradosso della felicità»: con l’aumentare del reddito, la felicità cresce, ma fino a un certo punto, per poi diminuire seguendo una curva ad U rovesciata, come nel grafico che segue:
Da allora di studi simili ce ne sono stati molti ed hanno cercato di individuare quali fossero i livelli di reddito e patrimonio che consentono di raggiungere l’apice della curva, corrispondente al livello più elevato di felicità. Gli importi del reddito individuati tendono ad oscillare nei differenti studi, per un ricco Paese occidentale, fra i 60.000 e gli 80.000 euro annui per un single, soglia oltre la quale i livelli di felicità si stabilizzano per poi incominciare a diminuire. Se sulle cifre precise c’è poco accordo, resta il fatto che ormai appare inattaccabile la teoria che una volta soddisfatti i bisogni di base (come cibo e vestiti), ma anche la possibilità di curarsi in modo decente, studiare, divertirsi di tanto in tanto, avere soldi in più non solo non renda più felici, ma si ritorca contro, rivelandosi un fattore di infelicità. Infatti, livelli di consumo più elevati sembrano fornire un maggiore grado di felicità solo in un primo momento: secondo il cosiddetto fenomeno dell’adattamento edonistico, l’effetto piacevole ed il maggior livello di benessere conseguente a livelli di consumo più elevato si affievolisce rapidamente e dopo un miglioramento temporaneo si ritorna al livello precedente, rendendo gli individui costantemente insoddisfatti. Peraltro, livelli assai elevati di consumo sembrano ad un certo punto ridurre i livelli di felicità per una sorta di assuefazione al benessere: se la felicità è legata ai desideri, la possibilità di permettersi “tutto” conduce al paradosso di un elevato grado di insoddisfazione.
Inoltre, molti studi mostrano che la tipologia dei nostri consumi sembra avere un ruolo fondamentale nel determinare il grado di felicità, poiché non tutti i consumi contribuiscono positivamente allo stesso modo:
· “esperienze”, come ad esempio i viaggi, sembrano contribuire maggiormente ed in modo più duraturo ai livelli di felicità rispetto all’acquisto di beni materiali, come una macchina più costosa o dei gioielli più preziosi;
· gratificazioni future più grandi tendono ad avere un maggiore effetto sui livelli di felicità rispetto a gratificazioni immediate minori e più frequenti;
· spendere i soldi anche per gli altri ci rende più felici del farlo solo per noi stessi;
· il denaro rende più felici quando siamo in grado di comprare del tempo, riuscendo a sottrarci all’incombenza di fare qualcosa per dedicare tempo al proprio benessere personale ed alla convivialità.
Il tempo, insomma, e la qualità del modo in cui lo impieghiamo, sembra essere il lusso del nuovo millennio, caratterizzato da livelli di ansia e stress sempre più diffusi e dalla percezione di una sua crescente scarsità. Come ha scritto l’Ocse nel suo “Better life Index”, che confronta i livelli di benessere nei vari Paesi, «la capacità di destreggiarsi tra vita familiare, lavorativa e personale influenza il nostro benessere e incide anche sui membri della nostra famiglia e su quanto tempo dedichiamo alla nostra vita sociale».
“Spendere” bene il proprio tempo in un lavoro che si ama e che si svolge con passione sembra contribuire maggiormente al benessere economico più di quanto possa fare la mera ricompensa economica nello svolgerlo; trovare il giusto equilibrio fra il tempo del business e quello della famiglia, condividere beni ed emozioni con gli altri, sembra essere la vera chiave della felicità piuttosto che livelli di spesa crescenti e la mera accumulazione di beni materiali.
Inoltre, la ricerca psicologica ed economica ha individuato nella capacità degli individui di sviluppare progetti e pianificare il futuro un elemento fondamentale per sconfiggere la tendenza negativa alla preferenza delle gratificazioni immediate minori rispetto a quelle future più grandi. La felicità, insomma, è figlia anche della motivazione nel porsi obiettivi di vita ambiziosi, realistici e soddisfacenti.
Dunque, per gli economisti moderni la formula della felicità sembra risiedere in un “giusto” mix di redditi moderatamente elevati, passione per il proprio lavoro, equilibrio tra tempo lavorativo e tempo libero, altruismo e qualità delle relazioni sociali, nonché nella capacità di perseguire soddisfacenti obiettivi di lungo termine, facendo del denaro uno strumento per la loro realizzazione piuttosto che il fine, in quanto il fine di ognuno di noi è il benessere e la felicità.

Consulente Finanziario a Napoli. Ti aiuto a fare le scelte finanziarie più efficaci in base ai tuoi progetti di vita.